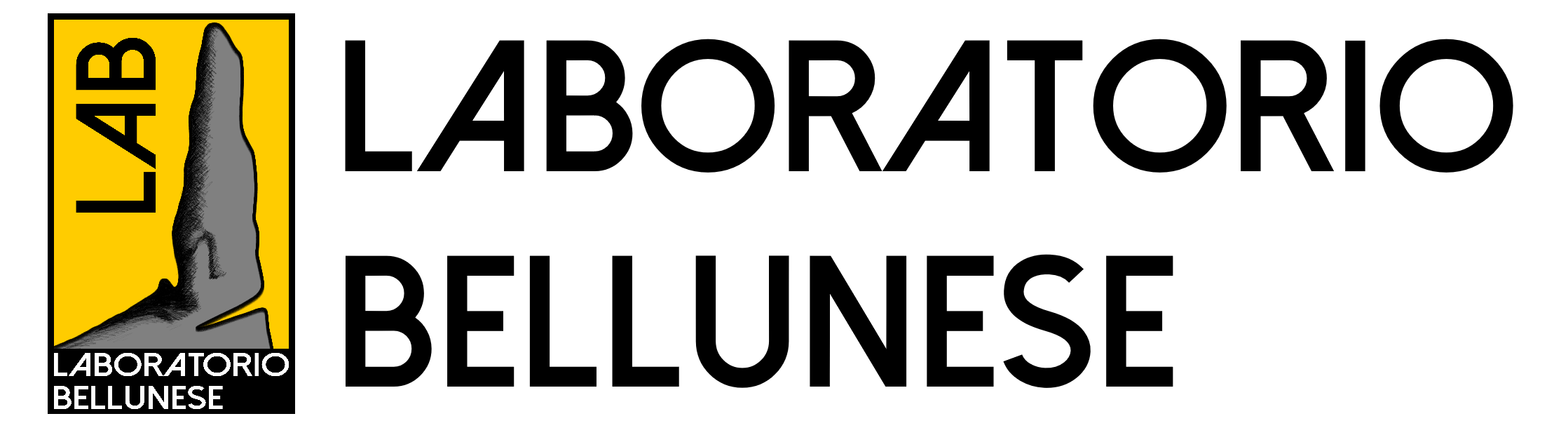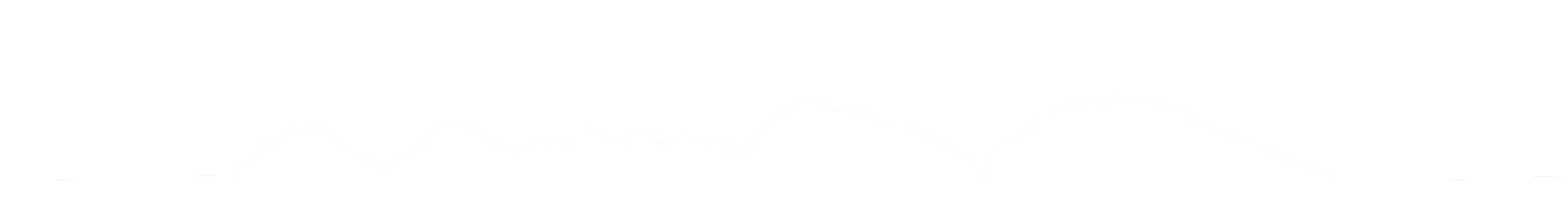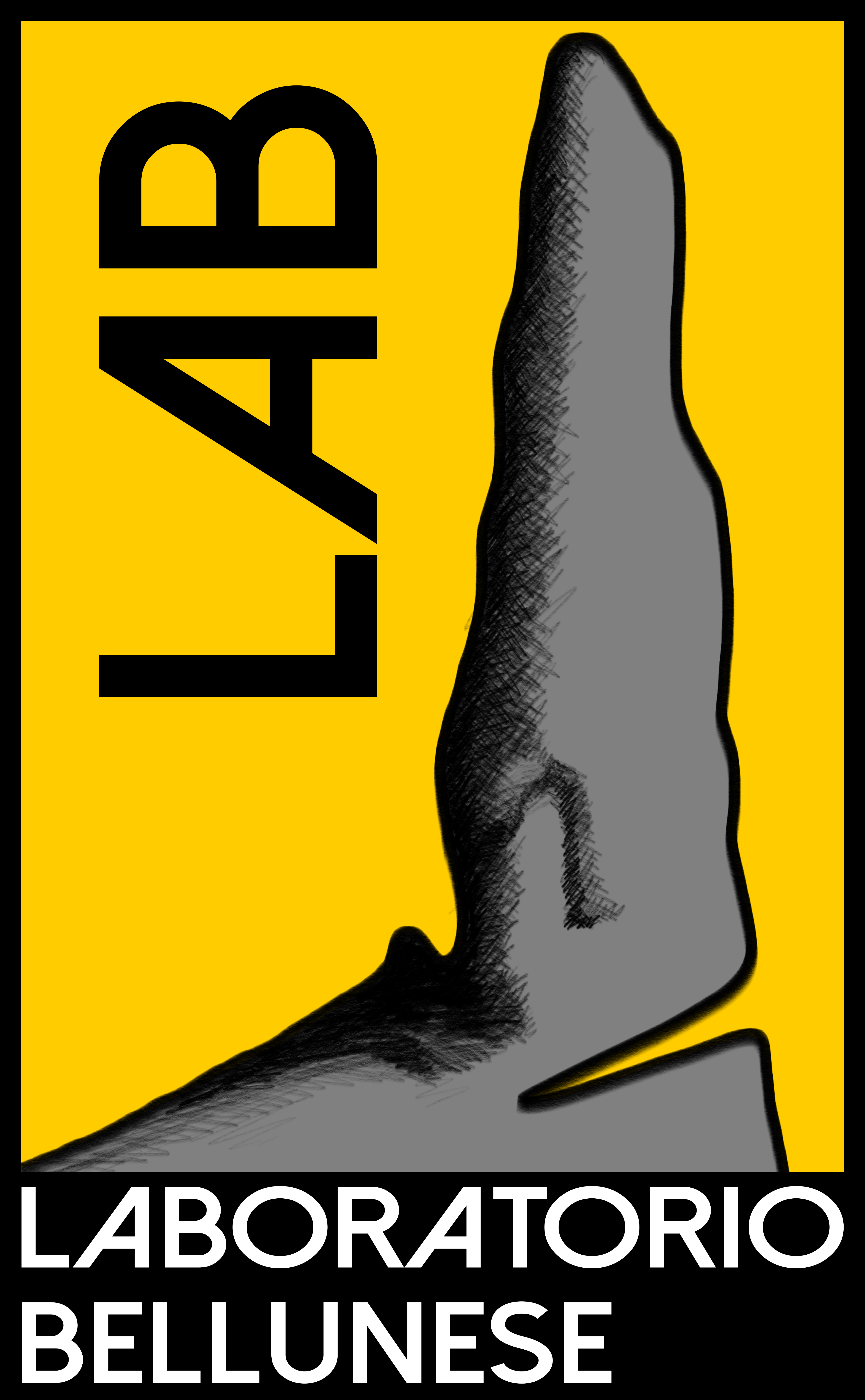È stato usato per medicare ferite, colorare filati ed è il responsabile della più potente esplosione non-nucleare della storia dell’uomo, di chi stiamo parlando? Ma dell’acido picrico ovviamente, sostanza che ha lasciato un segno indelebile nella storia!
Acido Picrico
C6H3N3O7
È stato usato per medicare ferite, colorare filati ed è il responsabile della più potente esplosione non-nucleare della storia dell’uomo, di chi stiamo parlando? Ma dell’acido picrico ovviamente, sostanza che ha lasciato un segno indelebile nella storia!
Anche se oggi il suo impiego è limitato, continua ad essere un reagente fondamentale per ogni laboratorio metallografico che si confronti con gli acciai, ed in altri settori specialistici come l’istologia.
Ma da dove viene questa sostanza? La conosciamo davvero? Vediamo dunque di scoprire la sua storia e capire come farci i conti! Lavorare con questa sostanza richiede infatti la massima attenzione poiché le sue potenzialità distruttive non sono affatto un ricordo del passato!
Storia
Partiamo subito con la storia dell’acido picrico, comporto che nel novecento ha giocato su più campi: dalle ferite dei soldati alle esplosioni che hanno fatto tremare la Terra. Grazie al comodo toggle button, potrete scegliere tra due modalità di lettura: una versione seria e dettagliata per gli amanti della precisione storica, oppure una seconda versione più breve, in stile leggero e ironico, per chi preferisce un tocco di umorismo. A voi la scelta!
1771
Peter Woulfe scopre l’acido picrico
1841
Jean-Baptiste Dumas attribuisce il nome “acido picrico” alla stostanza.
1885
In Francia viene brevettato l’uso dell’acido picrico come esplosivo nei proiettili d’artiglieria
1914-1918
L’acido picrico viene ampiamente utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale
1917
L’esplosione ad Halifax della nave Mont Blank
La più forte esplosione non nucleare della storia dell’uomo!
2.9 chilotoni – 1600 morti – 9000 feriti
'20s
Declino dell’uso militare
L’origine dell’acido picrico risale al 18° secolo quando il chimico anglo irlandese Peter Woulfe, noto per aver ipotizzato che la wolframite potesse contenere un elemento chimico sconosciuto, scoprì che l’indaco (pigmento blu di origine vegetale), se trattato con acido nitrico, si trasformava in un colorante giallo. Woulfe sintetizzo così l’acido picrico!
Per la determinazione della sua formula e la scoperta del processo sintesi a partire dal fenolo si è però dovuto attendere fino al 1841. Sempre in quest’anno, il 2,4,6-trinitrofenolo ricevette dal chimico francese Jean-Baptiste Dumas il nome con cui tutti noi lo conosciamo: acido picrico. Dove “picrico” deriva dal Greco πικρός (pikros), che significa “amaro” ed è legato per l’appunto al gusto della sostanza. Solo a partire da questi anni si iniziò ad utilizzare la sostanza per la colorazione di lana e seta, essendo in grado di conferire una bella e viva colorazione gialla.
Già nel 18° secolo era stato notato che i sali di quest’acido sono esplosivi, ma solo dagli anni trenta del secolo successivo si iniziò a pensare di utilizzare la sostanza come esplosivo. Tanto non passò che questo pensiero si concretizzò, e, sul finire del 19° secolo, l’acido picrico divenne l’esplosivo d’elezione per la realizzazione di proiettili d’artiglieria. L’acido picrico si rivelò essere un composto rivoluzionario! Infatti, a differenza della nitroglicerina e della nitrocellulosa, possedeva un rilevante vantaggio: era in grado di sopportate lo shock dello sparo prevenendo dunque catastrofiche detonazioni della carica del proiettile di artiglieria all’interno della canna.
L’esplosivo prese il nome di “Melinite” in Francia, mentre in Inghilterra venne chiamato “Lyddite” ispirandosi al nome della città di Lydd, nel Kent, dove veniva fabbricato. L’impiego della sostanza come esplosivo si diffuse poi negli Stati Uniti, in Giappone ed in Russia: un vero successo per l’acido picrico!
Nonostante l’acido picrico avesse una resistenza agli shock superiore a quella di nitroglicerina e nitrocellulosa, la sostanza possedeva un problema tutt’altro che trascurabile… Infatti l’acido picrico a contatto con i metalli forma picrati metallici altamente instabili e molto sensibili a shock termici o meccanici. Si è infatti scoperto rapidamente che i proiettili di artiglieria riempiti di acido picrico diventavano pericolosi nel tempo ed erano soggetti a deflagrazioni non intenzionali a causa per l’appunto del contatto della sostanza con la spoletta o con le pareti metalliche del proiettile.
Per scongiurare questo problema gli utilizzatori cercano di stabilizzare la sostanza, formulando nuovi mix (Ecrasite, Shimose powder, Shellite, Tridite), oppure di evitare il contatto con superfici metalliche che vennero rivestite con cere o resine.
L’acido picrico è stato impiegato come esplosivo in diverse guerre ed in particolare durante la Prima guerra mondiale. Esso proprio in questo periodo si è reso responsabile della più potente esplosione artificale non nucleare: l’esplosione di Halifax (2,9 chilotoni).
La mattina del 6 dicembre 1917, un incendio della nave mercantile francese Mont Blanc, sviluppatosi in seguito ad una collisione con una seconda imbarcazione nel porto di Halifax (Nuova Scozia, Canada), determinò la detonazione dell’intero carico della stiva (2600 ton di esplosivi di cui: 2300 ton di acido picrico e 180 di TNT). L’esplosione, sentita ad oltre 200km di distanza, causò la morte di oltre 1600 persone ed il ferimento di altre 9000; a ciò si aggiunse la distruzione, o grave danneggiamento, degli edifici nel raggio di 2.6 km, che determinò la sostanziale distruzione dell’intera città portuale.
Quest’esplosione, che ha dimostrato ancora una volta la già ben nota instabilità del composto, accelerò il processo di sostituzione dell’acido picrico come esplosivo da artiglieria. Sostituzione che, a onor del vero, era già iniziata nei primi anni del ‘900 e prevedeva l’impiego del notevolmente più stabile, sebbene meno potente, tritolo (TNT – 2,4,6-Trinitrotoluene).
Tritolo che nasce negli anni ’60 dell’Ottocento in Germania ma che, proprio a causa della sua stabilità, ha celato per almeno trenta anni il suo potere esplosivo. Sarà proprio la Germania, nei primissimi anni del ‘900, ad iniziare ad utilizzarlo per la realizzazione di proiettili d’artiglieria.
I proiettili realizzati con il TNT, a differenza di quelli a base di acido picrico, detonavano dopo l’impatto permettendo dunque alla carica di deflagrare dopo aver fatto breccia nella corazza del bersaglio, massimizzando dunque i danni provocati.
Come detto, l’acido picrico è stato progressivamente sostituito, ed ai tempi della Seconda guerra mondiale era già sparito dalle scena (salvo qualche eccezione come la Shellite).
Di pari passo all’impiego bellico, l’acido picrico fu impiegato, sempre nei primi anni del Novecento, come antisettico e per il trattamento di ferite, ustioni, malaria, vaiolo e herpes.
Per capire cos’è sta roba e da dove viene bisogna andare indietro fino al 1700 per poi passare attraverso due guerre mondiali, con esplosioni che si sentono a centinaia di chilometri di distanza. Mica pizza e fichi!
Un po’ di storia
Torniamo al 1771, quando un chimico anglo-irlandese di nome Peter Woulfe, con il fiuto di un cacciatore di nuovi elementi decise di fare esperimenti con l’indaco. Gli venne l’idea geniale di trattarlo con acido nitrico, e bum! Da blu diventa giallo. Bingo! Aveva appena messo le mani su una sostanza che avrebbe fatto molto più che colorare i vestiti… È però il 1841 quando un chimico francese, Jean-Baptiste Dumas, gli diede il nome che tutti noi metallurgisti e pirotecnici conosciamo: 2,4,6-trinitrofenolo, o più semplicemente acido picrico. Ah, e “picrico” viene dal greco “pikros,” che significa “amaro” (sì, anche se non è roba da assaggiare).
Dal laboratorio al campo di battaglia
Per un po’, l’acido picrico venne usato per colorare lana e seta. Bello, no? Ma poi, grazie al solito spirito creativo dell’uomo, si scoprì che questo grazio colorante giallo è anche esplosivo! Jackpot! Da quel momento, l’acido picrico cominciò ad essere usato per fare saltare per aria cose, e intorno al 1880 diventa la star degli esplosivi d’artiglieria. In Francia lo chiamano “melinite”, in Inghilterra “lyddite” (per via della città di Lydd dove lo producevano), e si diffonde ovunque: Stati Uniti, Giappone, Russia… tutti lo vogliono! E tutti lo usano, soprattutto durante la Prima guerra Mondiale.
Ma attenzione, c’era un problema! Questa sostanza era tanto esplosiva quanto instabile… lui ed i suoi sali sono un po’ instabili! E proprio per questo motive a volte saltavano in aria cose così a caso, come i proiettili all’interno delle canne dei cannoni di artiglieria… Per evitarlo, si cercarono di rivestire i proiettili con cere e resine, ma non sempre funzionava visto che l’acido picrico a contatto con i metalli generava composti particolarmente instabili (picrati).
Arriviamo dunque al culmine di questa storia esplosiva: l’acido picrico divenne protagonista della più potente esplosione non-nucleare mai registrata. Siamo nel 1917, nel porto di Halifax, Canada. Una nave francese carica di 2.300 tonnellate di acido picrico, oltre a 180 tonnellate di TNT, esplose in seguito a una collisione. Il botto si sentì a oltre 200 km di distanza, con un bilancio devastante: 1.600 morti, 9.000 feriti e un’intera città praticamente rasa al suolo. Questa tragedia accelerò la sostituzione dell’acido picrico con il tritolo, un esplosivo meno potente ma decisamente più stabile.
Il ritiro dalle scene (quasi)
Dopo la Grande Guerra, l’acido picrico è stato sostituito in ambito bellico dal TNT, che sì, è meno potente, ma decisamente più stabile (e non esplode senza preavviso, che è già qualcosa). Tuttavia, l’acido picrico ha trovato altri campi dove brillare, letteralmente. Oggi lo si trova ancora nei laboratori metallografici di mezzo mondo. Se hai mai sentito parlare di attacchi metallografici come il Picral o il Vilella’s, sappi che il nostro amico giallo è ancora lì a fare il suo lavoro. Oltre che in metallografia, viene ancora impiegato in istologia e come reagente per analisi chimiche. Roba seria.
Attenzione!
Un avvertimento: l’acido picrico è tosto. È esplosivo e tossico, quindi bisogna maneggiarlo con le pinze (non di metallo!) e con le giuste precauzioni. Quindi, se mai ti capiterà di usarlo in laboratorio, ricorda: leggi le schede di sicurezza, un minimo quantitativo, sempre umido e ben lontano dai metalli, qua non si scherza! Non vorrai certo diventare la prossima leggenda esplosiva, vero?
In sintesi, l’acido picrico è un pezzo di storia che continua a far parlare di sé. Dalla guerra ai laboratori, questo composto ha lasciato un segno indelebile (giallo) nella chimica e non solo. Quindi, la prossima volta che sentirai parlare di acido picrico, saprai che dietro quel nome c’è molto più di una semplice sostanza chimica.
Impieghi moderni:
Nonostante l’acido picrico sia sostanzialmente uscito di scena, esso viene ancora utilizzato in alcune applicazioni di nicchia!
-
Metallografia
Se state leggendo questo articolo sapete sicuramente che l’acido picrico è l’ingrediente principale di utilissimi attacchi metallografici, guarda caso sviluppatisi agli albori della metallografia e proprio durante gli anni in cui la sostanza veniva massicciamente utilizzata in ambito bellico.
In particolare, troviamo l’acido picrico:- nel Picral (etchant no. 76 della ASTM E407), eccezionale per l’attacco di strutture perlitiche (non essendo fastidiosamente sensibile all’orientamento della cementite);
- nel famosissimo Vilella’s (etchant no. 80 della ASTM E407), valida soluzione per l’attacco di acciai inossidabili martensitici;
- nel picrato sodico alcalino (“Alkaline sodium picrate” – etchant no. 85 della ASTM E407ottimo reattivo per la colorazione della cementite, molto comodo per l’analisi di ghise e per l’attacco di campioni sottoposti a trattamento McQuaid-Ehn;
- nel reattivo Bechet-Beaujard (richiamato nella ISO 643 e compatibile con l’etchant no. 81 della ASTM E407) utile per rivelare i PAGBs (prior austenite grain boundaries).
-
Reagente per analisi specifiche
L’acido picrico trova impiego come reagente in varie tipologie di analisi; ad esempio, può ancora venire utilizzato:
- per rilevare la presenza di gelatina nel latte;
- per rilevare la presenza di zuccheri riducenti;
- determinare il contenuto di glucosio o creatinina nel sangue.
-
Istologia
L’acido picrico, oltre che nel campo della metallografia, viene ancora utilizzato in istologia.
Esso per esempio rappresenta, unitamente a formaldeide e acido acetico, uno degli ingredienti della soluzione di Bouin: ottimo fissativo utilizzato per preservare strutture di tessuti molli e delicati in quanto capace di bloccare i processi di distruzione della cellula.
Viene inoltre comunemente utilizzato insieme alla fucsina per differenziare collagene, citoplasma e muscolo nel metodo Van Gieson oppure trova anche impiego nella colorazione Picro Mallory utilizzata per evidenziare i vari componenti del tessuto connettivo.
Sicurezza e buone prassi di laboratorio:
La prima cosa da fare quando si ha a che fare con qualsiasi prodotto è, senza dubbio alcuno, leggere il relativo SDS (Safety Data Sheet) redatto dal produttore! Se lavori in un laboratorio metallografico, e sei alle prime armi, il consiglio è anche quello di dare una letta alla ASTM E2014. Questa norma fornisce delle linee guida di base per lavorare in sicurezza.
Il fatto che l’acido picrico sia stato utilizzato principalmente come esplosivo e che sia stato poi sostituito in favore del meno potente, ma più stabile, tritolo, dovrebbe mettere in allerta riguardo i potenziali rischi di esplosione.
Il pericolo principale associato a tale sostanza è proprio quello di esplosioni!
Per minimizzare i rischi di esplosione le raccomandazioni prevedono di:
- Acquistare il minimo quantitativo necessario e stoccarlo in armadi resistenti al fuoco.
- Mantenere sempre l’acido picrico umido. Conviene mantenerlo sempre coperto con acqua (distillata o demineralizzata) o scioglierlo in alcool etilico. In qualsiasi caso, si deve evitare che l’umidità scenda sotto il 30%. Un’umidità inferiore al 10% pone rischi veramente significativi e determina la classificazione di esplosivo di classe 1!
- Evitare la formazione di picrati instabili (eg. picrati metallici o picrato di calcio). Per tale motivo l’acido deve essere stoccato in contenitori di plastica, o vetro, facendo attenzione che a non impiegare tappi metallici. Spatole o utensili usati a contatto con il reagente devono essere realizzati negli stessi materiali. Ogni volta che si apre il contenitore dove si stocca bisogna pulire il tappo, il collo del contenitore ed i filetti in modo da evitare che rimangano tracce di acido o soluzione. Queste tracce, asciugandosi, lasciano cristalli di acido anidro sul filetto che potrebbero portare alla detonazione del contenitore alla successiva riapertura a causa della frizione.
- Il contatto con superfici di cemento porta alla formazione di picrato di calcio (molto instabile) e dunque eventuali fuoriuscite vanno subito gestite.
- Se trovate vecchi contenitori contenenti acido picrico anidro, o caratterizzati da tappi metallici o da evidente presenza di cristalli sulla filettatura, non apriteli o maneggiateli. Rivolgetevi ad un ente competente per gestire la cosa (artificieri)!
Fortunatamente, ad oggi, non sono stati riportati casi di esplosioni avvenute in laboratori!
In Laboratorio:
- Leggi la scheda di sicurezza!
- Utilizza dispositivi di protezione adeguati quando hai a che fare con l’acido picrico:
- Guanti (Nitrile o neoprene) a meno che non aspiriate ad avere delle mani di un bel colore giallo!
- Camice
- Occhiali
- Scarpe chiuse e pantaloni lunghi
- Lavora sotto cappa
- Qualsiasi altro DPI indicato sulla scheda di sicurezza
- Indica sempre sui contenitori le sostanze contenute.
- Considerando la tossicità e l’instabilità dell’acido picrico e di molti suoi prodotti, non fare nulla se non sei sicuro di quello che stai facendo! I rischi associati alla manipolazione di sostanze chimiche sono infatti numerosi e spesso specifici per le sostanze utilizzate. È consigliabile che gli utenti siano consapevoli dei possibili pericoli che possono essere visibili o invisibili ed avere conseguenze immediate o a lungo termine.
- Se lavori in un laboratorio metallografico e usi soluzioni calde di acido picrico, fai attenzione a non dimenticare recipienti sulla piastra riscaldante in quanto, una volta evaporato il solvente, possono detonare o comunque lasciare sul fondo dei pericolosi cristalli di acido picrico anidro!
- L’acido picrico, da buon acido organico, lascia velocemente evidenti macchie gialle su molte plastiche. Attenzione dunque alle superfici dei banchi di lavoro ed alle attrezzature.
Stoccaggio:
Al di là delle indicazioni già fornite riguardo i materiali di contenitori ed utensili, l’acido picrico (umido) e sue soluzioni vanno stoccate in luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da fonti di calore, l’ideale sarebbe lo stoccaggio in armadi resistenti al fuoro.
Il reagente va mantenuto all’interno del contenitore origingale sul quale è anche da apporti la data di apertura . Eventali sue soluzioni vanno sempre ben identificate.
I contenitori devono essere ben chiusi, puliti ad ogni uso per prevenire depositi di sostanza sulla filettatura e soprattuto devono essere controllati periodicamente per garantire che l’acido sia coperto d’acqua (umidità deve sempre essere superiore al 30%). Eventuali soluzioni non devono essere lasciarte evaporare.
La disposizione all’interno dell’armadio deve essere tale per cui anche in caso di incidenti (urti, caduta di recipienti o ripiani,…) non vi sia il contatto fra acido picrico e sostanza incompatibili.
Tossicità:
L’acido picrico non solo è un potente esplosivo (e potenzialmente in grado di formare composti esplosivi a loro volta) ma è anche tossico. La conseguenza principale dell’esposizione all’acido picrico è l’acidosi (metabolica e respiratoria) che rappresenta anche la tipica causa di morte. L’acido picrico inoltre agisce da disaccoppiante del metabolismo mitocondriale, può distruggere gli eritrociti, causare gastroenterite, nefrite emorragica ed epatite acuta.
L’esposizione in ambiente lavorativo avviene principalmente per contatto, dove l’acido picrico viene poi assorbito attraverso il derma.
Il rischio di inalazione è basso in quanto l’evaporazione è trascurabile. Tuttavia, nel caso in cui l’acido picrico sia asciutto, è facile raggiungere rapidamente concentrazioni dannose di particelle aerodisperse, ad ogni modo, proprio per il rischio di esplosione, non si dovrebbe mai incorrere in questa eventualità!
L’ingestione è un evento raro grazie anche al fatto che la sostanza è caratterizzata da un gusto amaro e sopratutto impartisce una ben viva colorazione gialla alle soluzioni (simil cedrata).
-
Esposizione acuta
Il contatto dermico con l’acido picrico è il caso più comune e può determinare una colorazione gialla della pelle, irritazione degli occhi e della pelle. Possono inoltre seguire reazioni allergiche, caratterizzate da gonfiore di pelle e mucose, gonfiore intorno agli occhi e, in rari casi, lesioni cutanee vicino all’area di contatto. L’esposizione sistemica può portare a nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, oliguria, anuria, colorazione della pelle, prurito, acne, convulsioni o morte. L’ingestione di 1-2 g di acido picrico possono determinare la morte.
-
Esposizione cronica
Un’esposizione prolungata può colpire Il fegato, i reni e il sangue. I capelli, la pelle e la congiuntiva dell’occhio possono diventare gialli, con una corrispondente visione gialla. Può verificarsi la formazione di cataratta, così come emolisi intravascolare. Il contatto ripetuto può infine portare all’insorgenza di dermatite da sensibilizzazione.
-
Cancerogeneicità
L’acido picrico ha prodotto effetti contraddittori in vari test di genotossicità, risultando positivo in alcuni e negativo in altri.na revisione condotta da un comitato del Consiglio della Salute dei Paesi Bassi nel 2002 non ha trovato dati pubblicati sulla tossicità a lungo termine, sulla cancerogenicità o sulla tossicità riproduttiva.
Limiti di esposizione occupazionale:
TLW e TLA
0.1 mg/m3
EU-OEL
0.1 mg/m3
MAK
skin absorption (H)
sensitization of skin (SH)
carcinogen category: 3
E per finire…caratteristiche chimico-fisiche!
Concludiamo questo articolo riportando le caratteristiche chimico-fisiche dell’acido picrico. Se visiti questa pagina da pc potrai consultare anche alcune sezioni della pagina PubChem dedicata alla sostanza!
Formula: C6H3N3O7 C6H2(NO2)3OH
Massa molare: 229.10 g/mol
Preferred IUPAC name (PIN): 2,4,6-Trinitrofenolo
Systematic IUPAC name: 2,4,6-Trinitrobenzenolo
Altri nomi: Acido Picrico; Picric acid; Carbazotic acid; Phenol trinitrate; Picronitric acid; Trinitrophenol; 2,4,6-Trinitro-1-phenol; 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene; TNP; Melinite; Lyddite; Acide picrique; Phenol trinitrate; Pikrinezuur; Pikrinsaeure; Pikrynowy kwas; Kyselina pikrova
Aspetto:
-
Secco: si presenta sotto forma di cristalli gialli;
-
10% < Umidità < 30% : si presenta sotto forma di cristalli umidi o di impasto formato da cristalli gialli ed acqua;
-
Umidità > 30% : si presenta come un’impasto formato da cristalli gialli ed acqua.
Odore: inodore
Sapore: amaro intenso
Densità: 1.767 g/cm3
Tensione di vapore: trascurabile (<<1 mmHg)
Densità relativa del vapore: 7.90 (Air = 1)
Temperatura di fusione: 122°C
Temperatura di ebollizione: esplode a 300°C
Flash Point: 150°C
pKa: 0.42 a 24°C
Formula: C6H3N3O7 C6H2(NO2)3OH
Massa molare: 229.10 g/mol
Preferred IUPAC name (PIN): 2,4,6-Trinitrofenolo
Systematic IUPAC name: 2,4,6-Trinitrobenzenolo
Altri nomi: Acido Picrico; Picric acid; Carbazotic acid; Phenol trinitrate; Picronitric acid; Trinitrophenol; 2,4,6-Trinitro-1-phenol; 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene; TNP; Melinite; Lyddite; Acide picrique; Phenol trinitrate; Pikrinezuur; Pikrinsaeure; Pikrynowy kwas; Kyselina pikrova
Aspetto:
-
Secco: si presenta sotto forma di cristalli gialli;
-
10% < Umidità < 30% : si presenta sotto forma di cristalli umidi o di impasto formato da cristalli gialli ed acqua;
-
Umidità > 30% : si presenta come un’impasto formato da cristalli gialli ed acqua.
Odore: inodore
Sapore: amaro intenso
Densità: 1.767 g/cm3
Tensione di vapore: trascurabile (<<1 mmHg)
Densità relativa del vapore: 7.90 (Air = 1)
Temperatura di fusione: 122°C
Temperatura di ebollizione: esplode a 300°C
Flash Point: 150°C
pKa: 0.42 a 24°C
Liberatoria
LAB – Laboratorio Bellunese di Di Benedetto Daniele non è responsabile della qualità o della correttezza delle informazioni qui riportate né dell’uso che ne verrà fatto. Le informazioni fornite hanno carattere generale e non si sostituiscono in modo alcuno a quelle indicate nelle schede di sicurezza redatte dai produttori di reagenti, in documenti normativi o legislativi, o in altri documenti applicabili.